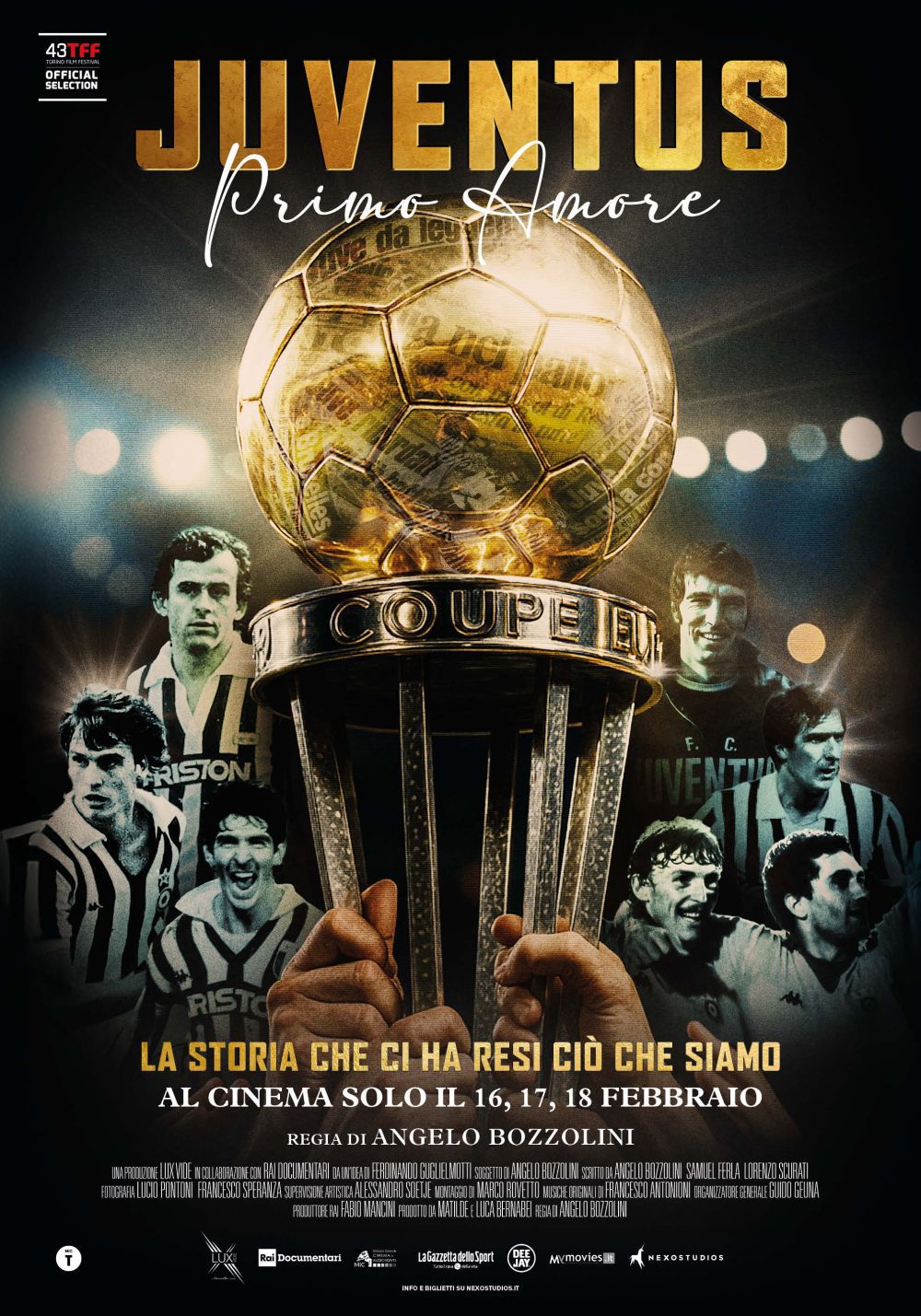Immagine di copertina: Foto della versione originale manoscritta delle regole del gioco risalenti al 1863, in esposizione al National Museum a Manchester
Compiuto a larghe ali questo volo sui 160 anni e passa del regolamento del gioco più amato, cercherò adesso di fissare le date più significative di questa evoluzione ancora in corso. Ho diviso l’intero processo in fasi di tendenza prevalente e nella prima, definita costruttiva, si delinea l’impianto logico del gioco e la sua applicabilità universale.
Vediamo alcune delle riforme più importanti e curiose in questo settore. Forse non tutti sanno che già nel 1868, quasi vent’anni prima della nascita dell’IFAB, si era già sentita la necessità di introdurre i tempi supplementari e che nello stesso anno sono stati definiti con precisione il concetto di gol e di corner. E già che si parla di quest’ultimo, è interessante sapere che solo nel 1924 sarà concesso di segnare direttamente da calcio d’angolo.
È del 1886 la limitazione data al portiere di usare le mani solo nella propria metà campo, ma solo nel 1913 gli sarà ulteriormente limitata questa libertà nell’era di rigore, come tutt’oggi.
Altre curiosità: il fuorigioco nasce nel 1887, ma prevede tre giocatori tra l’attaccante e la linea di porta e solo nel 1924 essi saranno ridotti a due, compreso eventualmente il portiere; il calcio di rigore nasce nel 1891 e sei anni dopo vengono definite le squadre di 11 giocatori e i 90 minuti di gioco, mentre solo nel 1898, l’anno successivo, viene delineato il terreno di gioco, terreno che rimarrà comunque sempre con misure piuttosto elastiche.

Solo nel 1902 vengono segnate con gesso o carboncino le linee di metà campo e le aree di rigore e di porta, ma solo nel 1938 esse saranno ufficialmente approvate dall’IFAB. Anche il 1904 è un anno importante, non tanto sul piano strettamente relativo al regolamento quanto perché la già esistente FIFA riconosce ufficialmente l’autorità dell’IFAB in competenza appunto di regole, codici e sanzioni e della loro applicazione in ogni angolo del mondo dove si giochi a calcio. In pratica, già ovunque.
Nel periodo successivo, bellico, postbellico, colmo di tensioni razziste e dittatoriali, prebellico e di nuovo in armi, c’è poco tempo, spazio e voglia per filosofeggiare su regole e disciplinari del football e, con la sola eccezione delle già menzionate riforme del 1924, non succede nulla di interessante. Nel 1937, il grande Stanley Rous passa dalla Football Association all’IFAB portando però al regolamento più chiarezza che riforme, la più significativa delle quali, nel 1948, è il disegno del semicerchio sul lato lungo dell’area di rigore a definire il limite oltre il quale devono stare i giocatori in occasione di un penalty. Insomma, niente di che. Bisognerà attendere ben altri 22 anni per apprezzare qualche modifica significativa!
E il 1970, anno dei Mondiali in Messico, segna anche la prima svolta epocale nella storia del regolamento. Il quale, avendo raggiunto una sufficiente, ma mai definitiva, maturità strutturale, necessita ora di qualche tocco che lo renda più interessante, appetibile e spettacolare e che, nel contempo, renda più difficile il ricorso a espedienti noiosi e troppo utilitaristici. Per tutti questi motivi, definiremo questa seconda fase ‘estetica’.

Le prime novità sono proprio del 1970: cartellini gialli e rossi, calci di rigore dopo supplementari vani e, soprattutto, sostituzioni. La storia evolutiva di queste ultime meriterebbe un lungo capitolo a parte, anche perché la loro introduzione e il loro sviluppo di regolamento ha inciso profondamente, secondo me, nella stessa concezione dello svolgimento della partita e, in ultima analisi, nella Storia del Calcio. Basti pensare che, nel giro di mezzo secolo, si è passati da poter sostituire solo il portiere a cambiare mezza squadra a partita in corso.
Non solo, ma, attraverso vari aggiustamenti, si è passati dall’avere in panchina il sostituto già designato, poi diversi sostituti prefissati, fino all’attuale modo che prevede l’intera rosa della squadra a bordo campo, con la più ampia possibilità di scegliere, di volta in volta, il designato a entrare. Obiettivamente, tutto un altro vivere…
Bisogna poi attendere altri 13 anni per un nuovo piccolo aggiustamento e quello del 1983, pur rimanendo nel solco estetico, introduce e anticipa il concetto della terza fase che chiameremo ‘correttiva’. La ‘regola dei quattro passi’, che costringe il portiere a liberarsi del pallone in fretta obbedisce all’esigenza di limitare la perdita di tempo da parte di squadre in difficoltà, inferiori o in vantaggio.
A parte il fatto che questo dell’atteggiamento sleale sul tempo di gioco è problema tutt’altro che risolto e più che mai dibattuto e attuale ancor oggi, questa regola inaugura una nutrita serie di norme che si dimostreranno solo parzialmente o per nulla efficaci e che avranno vita breve, perché cambiate e migliorate o perché definitivamente abbandonate. Nella fattispecie, quella dei ‘quattro passi’ diventerà nel tempo ‘dei sei secondi’ (2000) dopo essersi già evoluta nel divieto di afferrare con le mani un passaggio del compagno (1992). Nel frattempo, tornando addirittura ai provvedimenti ‘costruttivi’, a partire dai Mondiali nostrani del 1990 si è cominciato a mettere mano a uno dei complicati gangli insiti nella regola del fuorigioco e da allora un giocatore in linea con l’avversario non è più considerato in fallo.
Da quella competizione è stata inoltre inasprita la lotta contro il gioco duro e il gioco sleale, mentre da quella successiva, nel 1994, oltre a un primo allargamento delle sostituzioni, due più il portiere, si è introdotta la regina delle regole rivelatesi fallimentari: il Golden Gol. Il gol cioè che, segnato nei supplementari decretava l’immediata fine della gara, a ovvio vantaggio di chi l’aveva segnato. Che ci fosse qualcosa di contrario allo spirito del gioco era apparso chiaro abbastanza presto, ma ci sono voluti ben otto anni, a dimostrazione della sempre poco apprezzata rigidità autoritaria dell’IFAB, per attenuarla in Silver Gol (2002).
Questa modifica faceva sì che la gara durasse almeno fino alla fine del supplementare in corso, primo o secondo che fosse. Ma, esattamente come del resto la sua progenitrice, invece di favorire lo spettacolo e il gioco spregiudicato in attacco, aumentava la prudenza delle squadre, vanificando le migliori intenzioni dei promotori. Questa volta l’ente supremo preposto sarebbe stato meno titubante e già nel 2004 il Silver Goal è scivolato nel nulla stabilendo il record, imbattuto e imbattibile, di durata breve di un regola del Giuoco del Calcio: due anni scarsi.
Detto che dal 1995 non ci sono più i soli classici numeri dall’1 all’11, ma ciascun giocatore ha, oltre al proprio numero (dall’1 al 99), anche il nome stampato sul retro della maglia, a beneficio di pubblico e arbitri e che sono del 1998 l’ammonizione per simulazione e l’espulsione per gioco violento, c’è un provvedimento del 1999 che, per moltissimi aspetti, risulta propedeutico per ciò che capiterà una ventina d’anni dopo e che capita tuttora.
Mi riferisco ovviamente alla ‘prova televisiva’, quella che consente a posteriori un provvedimento disciplinare per un episodio sfuggito agli arbitri in campo. Il sostantivo incendiario di questa semplice descrizione è, incredibile ma vero, ‘sfuggito’. Facendo mente locale alle diatribe, giornalistiche, dirigenziali o da Bar Sport che fossero di allora, sembra di riecheggiare quelle più o meno analoghe di adesso sul protocollo VAR. Allora erano vivisezioni etimologiche di ‘sfuggito’: non visto? Impossibilitato a, impallato da? Distratto? Derubricato, giudicato erroneamente? E, quindi, si può applicare la prova tv? È un abuso? Un sopruso? È sacrosanto?
E non è forse la stessa cosa, oggi? Quando le domande sono: ‘Ma non poteva andarlo a vedere?’, ‘Se l’arbitro in campo fa segno di aver visto e giudicato tutto, può essere chiamato al monitor?’ ‘Che cosa si intende per “chiaro errore” e quando può essere corretto?’. Sono solo tre delle mille domande lecite che ci si pone, tra etica, filosofia del diritto e invasione tecnologica, nel calcio di oggi e che alimentano, tra l’altro, decine di trasmissioni televisive e radiofoniche che non parlano d’altro e che, per questo motivo, toccano picchi d’ascolto elevatissimi, introitando di conseguenza un sacco di soldi dalla pubblicità.
Ma del mondo complesso del VAR parlerò tra poco, prima cerco di portare a conclusione la storia del regolamento in quanto tale affrontando quindi, saltando il fatidico 2016, quelle più significative tra le recenti modifiche. Esse sono quasi tutte del tipo ‘correttivo’, cioè tendenti ad arginare simulazioni, perdite di tempo e, in ultima analisi, riduzione dello spettacolo. Ecco quindi che non c’è più la palla contesa ed essa rimane a chi l’aveva in possesso prima dell’interruzione (2019), il giocatore sostituito esce dal punto del campo più vicino a lui e non più dalla linea di metà campo (2019) e così via.
Quindi nulla di rivoluzionario, mentre lo è molto di più il passaggio dalle tre alle cinque sostituzioni avvenuto nel 2020, quando i campionati sono ripresi dopo la lunga sosta per il lockdown dovuto alla pandemia del Covid. È appena utile ricordare che quella ripresa dei tornei, a stadi vuoti per legge, contemplava un numero cospicuo di gare di recupero, con intervalli tra un impegno e il successivo di tre giorni, a volta solo due. Per favorire il ripristino di energie ed evitare i traumi, molte federazioni nazionali hanno allora concesso i cinque cambi. Sembrava una norma transitoria, e invece si è notato, certamente a posteriori, che questa concessione poteva far evolvere il gioco sul piano tattico in modo molto interessante e inatteso e così, alla fine, si è deciso di trasformarla in regola definitiva.
Questa è stata l’ultima modifica significativa del grosso faldone del regolamento, anche se altre ce ne sono state dopo, come del resto anche prima del 2020 e non menzionate, ma tutte di importanza marginale o comunque minore. L’unica che val la pena ricordare è l’introduzione di sensori nel pallone e nelle strutture della porta in modo che l’arbitro, dotato di apposita apparecchiatura al polso, possa certificare subito l’assegnazione o meno della marcatura. Applicato già nel 2013, si è trattato di un progresso correttivo molto importante, ma non certo rivoluzionario del gioco.
2- Continua